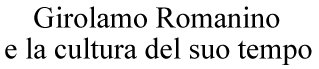|
Anni ottanta del Quattrocento. Tre polizze d' estimo indicano date varie, tra il 1484 e il 1487, per la nascita a Brescia di Girolamo Romano, detto il Romanino. È figlio di Luchino, la famiglia è da un secolo ormai insediata a Brescia, originaria di Romano di Lombardia.
La città in cui cresce Romanino, fin oltre la soglia del Cinquecento, è in notevole sviluppo economico. Dal 1428 è inserita nell' economia-mondo della Repubblica Veneta: è florida nelle ferrarezze, nel lanificio e nella gelsicoltura, si avvia alla diretta manifattura della seta.
Il centro cittadino è in rapida trasformazione nel segno del decoro e della magnificenza: vi sono attivi scultori e maestri impegnati nella decorazione della Loggia, del Monte Vecchio di Pietà, della Chiesa dei Miracoli
Quando però, nel 1508-9, Romanino è già alla testa di una sua bottega - come risulta dal contenzioso per il pagamento degli affreschi nel palazzo di Nicolò Orsini a Ghedi - la città va precipitando in eventi tragici: nelle guerre della Lega di Cambrai contro l'espansionismo veneziano in terraferma, sconta nel 1509 l'ingresso del re Luigi XII di Francia (dopo la disfatta dei veneziani ad Agnadello sull'Adda, vicino a Treviglio), quindi nel 1512 il terribile Sacco da parte delle truppe del condottiero francese Gaston de Foix, che la lascia in condizioni disastrose, la popolazione falcidiata (almeno 8mila gli uccisi), provata da congiure, pesti e carestie nel continuo transito di eserciti francesi, austro-spagnoli, fino alla definitiva riconquista da parte dei veneziani, nel 1516. Questi travagli stimoleranno nuovi spiriti caritativi, con la fondazione a Brescia, già dal terzo decennio del Cinquecento, di istituzioni assistenziali.
La pittura del Romanino trarrà da tante peripezie della sua terra una galleria di tipi esotici, di ceffi e soldataglie lanzichenecche a dare un tormento di vissuto - e non solo di stile - a certe fisionomie popolane così come a figure dalla gestualità ora violenta ora ispirata ad un' accorata pietà, di cui fu testimone in quegli anni. Romanino, in quello che sarà letto dalla critica del Novecento come il suo anticlassicismo, dimostrerà di essere uno dei pochi
artisti del suo tempo che hanno avvertito sconvolgimenti civili e drammi religiosi. Guerra, carestia, peste, miseria sono elementi evidenti d'un dramma collettivo del mondo popolano, ma i precedenti stilistici per trasporre nella pittura questo mondo Romanino non potè trovarli che nell' animazione brulicante di figure dell' arte tardogotica del Quattrocento fiorita lungo i corsi del Reno e del Danubio, fatta conoscere al di qua delle Alpi attraverso le incisioni.
Il più consapevole interprete dell' incontro tra la mistica tedesca, che avrebbe alimentato la Riforma di Lutero (l' anno della rottura dalla Chiesa di Roma è il 1517), e lo studio umanistico delle statue antiche, dell' anatomia e della prospettiva,
fu Albrecht Dürer, che nel 1506, con la Festa del Rosario, aveva lasciato a Venezia in S. Bartolomeo, la chiesa dei Tedeschi, un' opera che Romanino potè vedere e capire nel suo farsi azione sacra nel paesaggio. Nella propria terra invece Romanino trovava nelle sacre rappresentazioni i precedenti che gli avrebbero permesso di ricondurre il sacro all' esperienza quotidiana.
È tradizione, pur senza notizie precise, ma con inoppugnabili riscontri nelle opere, collocare la formazione di Romanino
tra Brescia e Venezia. Brescia era la città di cui s'è detto. La Venezia al passaggio tra Quattro e Cinquecento era stata qualificata dall' ambasciatore francese Philippe de Commyens la città più bella e trionfante del mondo,
metropoli del commercio e della cultura. Era la città che stampava più libri di tutta l'Europa messa assieme.
Romanino matura dunque in un quadro quanto mai stimolante di incontri, di trasformazioni, di prospettive.
Fausto Lorenzi
|